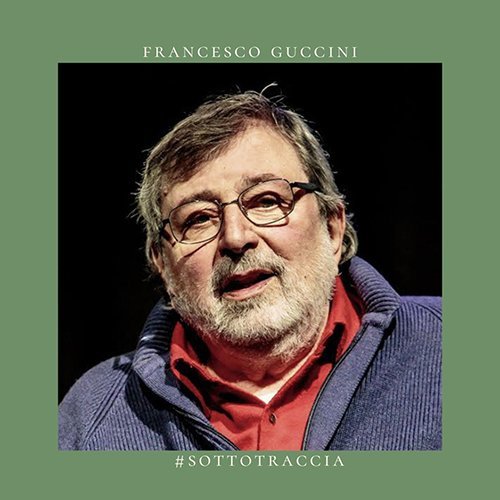Come da tradizione (recente) dedichiamo agosto alla lettura: per il 2024 abbiamo deciso di ripubblicare una serie di pagine tratte dal volume “Italia d’autore” (Arcana, 2019), dedicato ai grandi cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana.
Francesco Guccini nasce a Modena il 14 giugno 1940. Sua madre Ester fa la casalinga, suo padre Ferruccio è impiegato alle Poste, anche se poco dopo la nascita di Francesco deve mettere una divisa e partecipare alla Seconda Guerra Mondiale. Così Ester e Francesco si trasferiscono a Pàvana, sull’Appennino, presso i nonni paterni. È un periodo che rimane impresso nella sua memoria, anche perché numerosi saranno gli episodi e i personaggi che lo costelleranno.
Ma già nel 1945, alla fine della guerra, Ferruccio torna dalla prigionia tedesca, riprende l’impiego alle Poste e trasferisce la famiglia a Modena. Ma Modena, a parte qualche amico come Cencio, non riempie di gioie l’infanzia e l’adolescenza di Francesco: ne parlerà più avanti, nella poco amichevole Piccola città: «Piccola città, bastardo posto/appena nato ti compresi o fu il fato che in tre mesi mi spinse via».
Forse è colpa di Modena, forse è colpa di Guccini: «correva la fantasia verso la prateria, fra la via Emilia e il West…». Frequenta l’istituto magistrale Sigonio, lo stesso da cui è passato Pavarotti, e al contrario di tantissimi l’insegnamento non lo spaventa. Anzi, il primo lavoro sarà in un collegio a Pesaro ma l’esperienza termina con il licenziamento. Così prova a conservare lo stesso strumento di lavoro, le parole, ma con uno scopo diverso: per due anni è cronista alla Gazzetta di Modena, specializzato soprattutto in cronaca giudiziaria.
Ma nell’aprile del 1960 ha la ventura d’intervistare Domenico Modugno: l’incontro spinge Guccini, già autore di brani rock’n’roll, a considerare la possibilità di scrivere anche canzoni “da cantautore”. La prima sarà L’antisociale, che segnerà una svolta rispetto agli esordi con le balere e le piccole band, a seguire le orme dei rocker e dei bluesman americani. Fa anche il chitarrista per una tournée svizzera di Nunzio Gallo, mentre nel 1961 si trasferisce a Bologna con la famiglia e s’iscrive a Lingue. Per un certo tempo divide l’alloggio con Alfio Cantarella, poi nel 1962 parte per Lecce per il servizio militare, che trascorre anche scrivendo qualche altra canzone, però cestinata per vergogna.
Quando torna scopre che la sua band, i Gatti, si è unita con i Giovani Leoni di Maurizio Vandelli: rifiuta di entrare nel nuovo gruppo per proseguire invece gli studi e così Vandelli e gli altri continueranno, sotto il nome di Equipe 84. Nel frattempo ascolta le canzoni dei Cantacronache, quelle di Bob Dylan e comincia a scrivere pezzi che piacciono perfino a lui: per esempio Auschwitz, nata come La canzone del bambino nel vento, oppure È dall’amore che nasce l’uomo, o ancora Noi non ci saremo.
Guccio si mette in proprio
Guccini è visto, all’epoca, come un ottimo autore ma forse non come un potenziale interprete. Nel 1967 la CGD gli propone di partecipare al Festival di Sanremo come autore della musica di Una storia d’amore, interpretata da Caterina Caselli e Gigliola Cinquetti. Si apre però un piccolo caso: racconta Roberto Vecchioni, all’epoca fra gli autori CGD, che la casa discografica gli impone due parolieri professionisti, i famosi Pace e Panzeri, per modificare il testo della canzone. Ma Guccini non è proprio quello che si dice un personaggio accomodante: si irrita a tal punto che rinuncia a ulteriori collaborazioni. Così si mette in proprio: arriva Folk beat n.1, firmato soltanto Francesco, un po’ come fanno oggi i cantanti usciti dai talent show; se avesse saputo, Guccini, probabilmente avrebbe aggiunto il cognome anche a penna, copia per copia.
Il disco è un flop, eppure contiene alcune perle assolute della sua musica: oltre alle già edite Auschwitz e Noi non ci saremo, ci sono gli omaggi a Dylan Talkin’ Milano e Statale 17, ci sono canzoni politico-storiche come 3 dicembre del ’39, ci sono brani appassionati e disperati come Canzone per un’amica, qui ancora con il titolo originale di In morte di S.F. Ma forse è troppo presto: prima ci vuole la censura a Dio è morto, che i lungimiranti funzionari Rai ritengono un attacco alla religione, mentre la trasmette Radio Vaticana e la apprezza Paolo VI, per dire dei tempi.
Guccini nel frattempo scrive canzoni che sono interpretate dai Nomadi, da Caterina Caselli, perfino da Lando Buzzanca. Nel dicembre 1968 debutta dal vivo, con un concerto tenuto nientemeno che al Centro culturale la Cittadella della Pro Civitate Christiana di Assisi. Lavora anche come autore di Carosello, mentre nel 1970 esce Due anni dopo, più intimista del precedente. Inizia a collaborare anche con Deborah Kooperman, chitarrista specializzata nella tecnica del fingerpicking, che lavorerà più o meno a tutti i suoi dischi.
La vita privata è turbolenta: è fidanzato con Roberta Baccilieri, ma parte per l’America con Eloise Dunn, che ha conosciuto al Dickinson College di Bologna dove insegna. Tornerà dall’America con idee di Dylan, con spunti di Hemingway, con la barba e senza Eloise. Si riconcilia con Roberta, va in vacanza in Grecia e inizia a pensare al nuovo disco, che sarà L’isola non trovata, con La collina, L’orizzonte di K.D. (“K.D.” è Karen Dunn, la sorella di Eloise), Un altro giorno è andato.
“Incontro” e “La locomotiva”
Nel 1971 si sposa con Roberta. Il salto qualitativo, in musica, arriva con Radici, del 1972: la musica, al contrario dell’immagine stereotipata che si ha dei cantautori italiani “alla Guccini”, è molto curata, anche grazie al contributo di personaggi come Ares Tavolazzi e Vince Tempera. I sette pezzi che volano via nell’ascolto del disco colpiscono però anche per i testi: ci sono vertici assoluti come Il vecchio e il bambino e Incontro, di cui Guccini racconta così la nascita:
Incontro parla di un’amica mia che, bontà sua, era innamorata di me. Era anche molto carina, ma aveva poche tette e io ero molto sensibile all’argomento. Oggi guardo altre cose, anche perché sono cambiati i tempi. In quegli anni avere la ragazza senza tette era un handicap mica da ridere. Con questa ragazza rimanemmo comunque amici. Diventò professoressa di ginnastica e si sposò con un americano che viveva a Bologna. Per un po’ vissero in America, poi si trasferirono a Berlino e fu lì che s’innamorò di un altro, un tipo piuttosto instabile, purtroppo. Così, quando a Natale lei raggiunse suo figlio in America, lui fece l’albero e s’impiccò. Al suo ritorno in Italia la mia amica venne subito a cercarmi per raccontarmi cos’era successo. Andai a trovarla e dopo quel pomeriggio trascorso insieme scrissi Incontro, forse il mio primo tentativo di scrivere per immagini veloci, molto cinematografiche.
[Francesco Guccini, Stagioni. Tutte le canzoni, a cura di Valentina Pattavina, Einaudi, Torino, 2000]
E poi, naturalmente, c’è La locomotiva: pezzo-bandiera, chiude ancora i concerti di Guccini e si è meritata perfino opere d’arte in dedica. E qui si sfugge dal concetto della musica leggera: Guccini costruisce la canzone sul racconto del viaggio disperato del macchinista anarchico Pietro Rigosi, che nel 1893 dirotta una locomotiva e la punta verso la stazione di Bologna. La vicenda si risolve in un incidente che costa al Rigosi una gamba, l’accusa di pazzia da parte dei giornali dell’epoca e una canzone, quella di Guccini, che ridipinge i passaggi della vicenda colorandola come la sfida dei disperati ai potenti.
Parole che riecheggiano negli anni: il macchinista è oggetto del verso secondo cui «gli eroi son tutti giovani e belli»; il contesto ferroviario è spiegato così: «i tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti/sembrava il treno anch’esso un mito di progresso». La strofa più politica in assoluto recita: «Ma un’altra grande forza spiegava allora le sue ali/parole che dicevano “gli uomini son tutti uguali”/e contro ai re e ai tiranni scoppiava nella via/la bomba proletaria e illuminava l’aria/la fiaccola dell’anarchia».
Da notare la vicinanza temporale tra La locomotiva e Locomotive Breath dei Jethro Tull, contenuta in Aqualung del 1971: data la somiglianza di alcuni concetti, ma non certo della matrice politica, e data l’attenzione di Guccini per la musica anglosassone, forse non è sbagliato pensare che qualche spunto possa essere arrivato anche da lì. Con La locomotiva si completa la trasformazione di Guccini in agente propagatore di valori e contenuti politici molto aperti, molto dichiarati, molto fastidiosi per alcuni, che inizieranno a considerarlo non un cantautore ma un portatore di etichette: comunista, provocatore, portavoce di una generazione e via discorrendo.
Il rischio, comunque, è calcolato: Guccini conosce il valore della parola, sa che certi testi non gli porteranno molte amicizie e non gliene importa nulla. Anzi, prosegue per la propria strada, incrociando ogni tanto anche quella altrui: come quella di Claudio Lolli, che aiuta agli inizi della carriera da cantautore. Nel 1973 esce Opera buffa, che mette in luce anche le sue qualità istrioniche e cabarettistiche: il disco è una specie di semi-live, che evidenzia la sua abilità, molto emiliana, di gigioneggiare con il pubblico, spesso cantando strofe quasi da taverna. Nel 1974, in mezzo a una profonda crisi psicologica, pubblica Stanze di vita quotidiana, che causerà una serie di polemiche e ripercussioni. Racconta Guccini:
Avevo un produttore, Pier Farri, che mi sballottava da Roma a Milano senza il minimo motivo. Fu terribile. Al tempo, Pier era fissato con l’esotismo, le marimbe. Ares Tavolazzi, il bassista, se ne andò quando Pier gli chiese di eseguire un suono giallo… cazzo voleva dire?
Piccole storie avvelenate
Altra polemica storica è quella con il critico Riccardo Bertoncelli, che a seguito del disco lo giudica “un artista finito”. Guccini risponde con L’avvelenata, una delle sue canzoni più celebri, in cui se la prende con i suoi critici: «Che cosa posso dirvi? Andate e fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete/un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate!». Poi i due s’incontreranno, chiariranno le divergenze e il cantautore si offrirà di togliere il suo nome dalla strofa, ma il critico rifiuterà l’offerta. In anni più recenti, in concerto, spesso il nome di Bertoncelli sarà sostituito da quello di un noto politico italiano, che inizia sempre per “Ber-” e che nell’attività descritta nel verso successivo è il maestro riconosciuto e impareggiabile.
Che però Guccini non sia proprio finito lo testimonia il fatto che Via Paolo Fabbri 43, uscito nel 1976, gli porterà anche il successo commerciale, risultando uno dei dischi più venduti dell’anno. Oltre a L’avvelenata ci sono Piccola storia ignobile, che parla di aborto, Canzone quasi d’amore e il pezzo che dà il titolo all’album, contenente un’altra piccola polpetta avvelenata nei confronti di alcuni cantautori, e segnatamente Venditti, De Gregori e De André. Guccini smusserà l’attacco nei confronti di De André, di cui è amico, ma la critica nei confronti dei colleghi è una costante della sua carriera.
Del resto, L’avvelenata colpisce anche qui: «Colleghi cantautori, eletta schiera/che si vende alla sera, per un po’ di milioni/voi che siete capaci, fate bene/a aver le tasche piene, e non solo i coglioni». Nel 1978 arriva Amerigo, la cui title track è canzone di importanza a diversi livelli per il cantautore: è la prima in cui suona Flaco Biondini, ma è anche il ricordo di uno zio emigrante, simbolo di un’America non così tanto scintillante.
Nel 1977 il settimanale «Grand Hotel» gli carpisce un’intervista che pubblica in copertina con il curioso titolo: Il padre che tutti i giovanissimi avrebbero voluto avere. Un tocco di fantasia che Guccini commenterà così, parlando con i fan che gli rinfacceranno l’apparizione su una rivista scandalistica: «Questo è niente, vedrete quando scriveranno: Liz Taylor grida a Guccini: rendimi il mio figlio segreto!». In maniera analoga a De André con la PFM, registra un disco dal vivo con i Nomadi, quindi incide Metropolis, album complesso ma non amatissimo.
L’alternanza tra altissimo, intellettuale, rarefatto e colto da una parte e popolare, terreno, quotidiano dall’altra si conferma anche nella pubblicazione del live, invece molto amato, Fra la Via Emilia e il West, del 1984: è il punto su una carriera di assoluta eccellenza, con un concerto in piazza Maggiore a Bologna, accompagnato da amici come Gaber, Vecchioni, l’Equipe 84, i Nomadi e Paolo Conte. Nel 1987 invece esce il curioso esperimento letterario Signora Bovary, in cui ogni canzone è dedicata a un personaggio della vita di Guccini, fino alla stessa Bovary che, come in Flaubert, “c’est moi”: è Guccini medesimo.
Croniche e farfalle
Nel 1989 c’è un nuovo esordio: è quello con la letteratura, con il venduto e apprezzato Croniche epafàniche, che racconta del periodo di Pàvana, cui faranno seguito Vacca d’un cane e altri tentativi letterari di vario genere. Gli anni Novanta vedono un Guccini più affermato e meno affamato di esperienze, anche se il ritmo rallentato con cui escono gli album gli permette maggior meditazione e, spesso, qualche capolavoro: nel 1990 esce Quello che non…, nel 1993 ecco Parnassius Guccinii, dal nome di una farfalla battezzata in suo onore, mentre nel 1996 è la volta di D’amore, morte e di altre sciocchezze, in cui sentimenti nuovi (Raffaella, in Vorrei), vecchi (Angela, in Quattro stracci) ed eterni (Cirano, scritta però da Bigazzi e Beppe Dati) congiurano a un disco complessivamente molto riuscito.
Stagioni del 2000 e Ritratti del 2004 arrivano a confermare come il cantautore sia ancora perfettamente in grado di scrivere di “Che” Guevara come di Carlo Giuliani, di duettare con chi gli deve molto e non l’ha mai nascosto, come Luciano Ligabue, ma anche di cedere una canzone a qualcuno cui forse deve qualcosa lui, come Adriano Celentano.
Nel 2011 sposa, in seconde nozze, Raffaella Zuccari, a confermare un rapporto stabile da quindici anni. Poi c’è la partecipazione al disco di Enzo Avitabile Black tarantella, nonché alle iniziative legate al sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto nel Modenese, cioè casa sua, culminate nel Concerto per l’Emilia del giugno 2012. E nello stesso 2012 esce L’ultima Thule, disco nuovo e ricco di spunti, inciso all’interno del mulino di famiglia a Pàvana, che mette un punto sulla carriera dell’impareggiabile “Guccio”: dichiara infatti che ne ha abbastanza di canzoni, album, tournée, e che da qui in avanti scriverà soltanto libri.
Nel 2006 qualche buontempone in Parlamento (non ne mancano mai) gli aveva regalato un voto durante l’elezione del presidente della Repubblica, episodio che si è ripetuto anche nell’elezione presidenziale del 2013, quando anche Francesco De Gregori ha ricevuto un voto. E in fondo, perché no? Quanti uomini, politici e non, possono vantare un seguito di giovani e di non giovani paragonabile a quello di Guccini? A quanti hanno dedicato non soltanto una farfalla ma anche una pianta tropicale? Quanti possono mettere insieme tante frasi di senso compiuto, a volte un po’ più che compiuto, allo stesso livello del professore/scrittore/cantautore modenese? Quanti possono dire di essere giunti ad avere idee altrettanto chiare, ma dopo una riflessione, e non perché, di idee, ne avevano una sola, e buttata a caso?