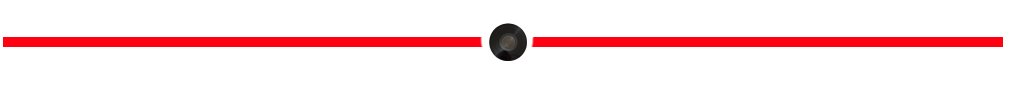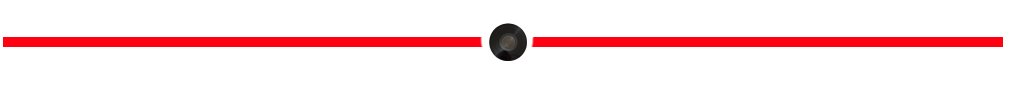
Partiamo da una notizia, riportata dalla BBC (che è sempre la BBC): secondo le previsioni, gli artisti UK nel 2020 perderanno due terzi dei loro guadagni (qui l’articolo originale). Due terzi. Stiamo parlando di un mercato musicale molto evoluto e sviluppato, sicuramente il più prolifico d’Europa. E, ovviamente, stiamo parlando di perdite che sono del tutto correlate alla cancellazione dei live. Facendo i conticini della serva, anche chi ha fatto il Classico (tipo me) ci può arrivare: gli introiti derivanti dallo streaming, Spotify, Youtube e simili, che presumibilmente non sono stati toccati dalla pandemia, anzi forse sono cresciuti, non incidono per più del 33%. E stiamo parlando dell’Inghilterra, non dell’Italia.
Da noi, presumibilmente, chi fa musica sta anche peggio: per quanto i live possano essere anche mal pagati, soprattutto per chi non riempie i palazzetti, spesso costituiscono l’unica forma di guadagno per chi suona, a ogni livello. Spotify permette la presenza, YouTube diffonde i video, Facebook consente relazioni con la fanbase, Instagram, TikTok, Twitch eccetera fanno sì che la popolarità si incrementi anche con le fasce di potenziali fan più giovani, che saranno pur sempre i fruitori di musica del futuro.
Ma niente ha sostituito quella che una volta era la vendita dei dischi, almeno a livello economico: non è per fare i nostalgici o i passatisti, è soltanto un dato di fatto. Che però, in un anno quasi senza concerti com’è stato il 2020 (e chi sa come sarà il 2021 ci faccia un colpo di telefono, così ci organizziamo) grava sui conti della musica in maniera incontrovertibile. La foglia di fico è volata via. Anzi è proprio bruciato l’albero di fico.
Ci sono soluzioni per questo tipo di situazione? Forse qualcuna sì. O almeno: c’è chi sta tentando strade diverse. Abbiamo parlato qualche giorno fa di Sale, nuovo disco dei C+C=Maxigross, band veneta avvezza alla sperimentazione sonora e, a quanto pare, non solo. Non si sono inventati marchingegni particolari: hanno sfruttato qualcosa che esisteva già, cioè la piattaforma di Bandcamp sulla quale vendono il loro disco. 13 euro (ma si può versare loro anche una cifra superiore, se lo si ritiene giusto) e si effettua un download in alta qualità del nuovo lavoro.
Fin qui niente di nuovo: lo facevano anche molti emergenti. E, a livello temporaneo, lo fanno anche altri: per esempio è uscito proprio oggi La rivoluzione del battito di ciglia, nuovo degli Yo Yo Mundi (qui la recensione), che per i primi tre mesi sarà disponibile soltanto in formato fisico, vinile e cd, quindi non caricato sulle piattaforme di streaming audio. La decisione è motivata sia dalla voglia di incentivare l’acquisto fisico del disco sia per permettere a tutti i loro sostenitori che hanno aderito al crowdfunding, di ottenere le “ricompense” senza trovare il disco ascoltabile ovunque.
Quella dei C+C=Maxigross però è una decisione definitiva, almeno riguardo a Sale. E si tratta di una band già consolidata e soprattutto che ha fatto una scelta di campo: il disco lo puoi ascoltare soltanto se lo scarichi da lì, su Spotify non lo trovi e non lo troverai. Abbiamo deciso di approfondire la questione. A partire naturalmente dai C+C: così abbiamo rivolto qualche domanda a Tobia Poltronieri, in rappresentanza del collettivo.

Partiamo dalle cose semplici (più o meno): come vi è venuta l’idea?
Nel nostro percorso personale è stata una scelta che è arrivata all’ultimo. A settembre abbiamo deciso di pubblicare soltanto su Bandcamp e di evitare di mettere questa musica nuova su Spotify. E questa è la prospettiva che almeno per il momento pensiamo di mantenere. Ci è venuto in mente riflettendo sul percorso degli ultimi anni sia nostro personale sia per quello che abbiamo visto intorno a noi. E’ stato un percorso molto lungo.
Fino al disco precedente, Deserto, uscito un anno fa, abbiamo gestito in maniera più classica, quindi Spotify eccetera. Abbiamo stampato per la prima volta anche un vinile, pratica molto dispendiosa anche se l’abbiamo fatto con l’etichetta discografica. Tutta la manovra per un gruppo piccolo come noi è stata molto impegnativa.
Siamo arrivati stanchi da tutto il processo e in più è andata male all’inizio, perché il disco non ha generato quel tipo di ascolto virtuoso: o la gente ti ascolta o non ti ascolta, qualunque sia il motivo. In più i pochi concerti che avevamo fissato sono stati interrotti a fine febbraio per tutta la situazione che si è generata nel mondo; ci siamo ritrovati con un blocco forzato, tanto tempo per fare un sacco di cose, tra cui trovare altri lavori extra musicali per sopravvivere, e ricercare qualcosa di nostro.
E poi nei mesi successivi, quando abbiamo pensato se pubblicarlo nella maniera solita, qualcosa non ci tornava. Nel momento in cui ti tolgono i concerti anche gli artisti su scala enorme, cioè le star delle star, quando mettono in moto la macchina del tour, comunque ottengono un fatturato inconfrontabile con le entrate delle piattaforme digitali. Inconfrontabili soprattutto con gli introiti che c’erano con i supporti fisici in vendita, fino a poco più di dieci anni fa.
Quindi da una serie di riflessioni su quale fosse la soluzione più adatta alla nostra situazione personale abbiamo pensato che forse valeva la pena di ripartire da noi stessi e da chi si fida di noi. Per quanto possa sembrare semplicistico, per noi si appoggia tutto lì: creare qualcosa su cui garantiamo un’onestà.
E credo che unendoci così si possa ripartire per una strada nuova.
Le possibilità offerte da Bandcamp tra l’altro sono piuttosto estese…
Abbiamo scelto Bandcamp perché è una piattaforma storica ma che dimostra una coerenza e un’eticità che si percepisce anche leggendo le interviste dei fondatori. Quando uno dice che ha creato una piattaforma per la musica e per gli artisti e poi ti spiega quali azioni concrete ha fatto, capisci che non sta idealizzando la musica e poi però ti dice, come il creatore di Spotify, che l’artista si deve adattare alla piattaforma. Ti dice esattamente l’opposto.
Hanno creato una piattaforma e un sistema economico in cui gli utenti si devono adattare per far sì che la macchina sopravviva. Per esempio in quest’ultimo anno, con un’iniziativa semplice come i Bandcamp Fridays, ogni primo venerdì del mese il portale non trattiene la percentuale delle transazioni economiche che avvengono, e pubblica quello che è rimasto direttamente agli artisti.
Noi ci siamo trovati molto bene dal punto di vista pratico. Questo lavoro di fidelizzazione e rapporto diretto con i propri ascoltatori o possibili ascoltatori è veramente molto importante. Per alcuni artisti potrebbe anche diventare la direzione principale verso la quale dirigersi in questo momento. Noi vediamo davanti a noi un mare da attraversare, ma avendo scelto un percorso indipendente siamo molto contenti del viaggio che abbiamo intrapreso.
Tra l’altro Bandcamp ha annunciato la possibilità di tenere concerti in streaming vendendo i biglietti attraverso la piattaforma. Qui bisognerebbe aprire un’altra parentesi sul fare musica in remoto perdendo la dimensione del live, che è argomento complesso. Però è positivo il fatto che stiano creando una struttura che ti permetta di rendere equilibrata e gestibile l’interazione con il pubblico: è proprio questo invece il problema delle dirette sui social, che rischiano di far sì che la musica sia data per scontata, come un contenuto che ti trovi sullo schermo gratis.
Ma consiglieresti questa soluzione tipo quella di Sale a un emergente senza una storia alle spalle?
Come questo sistema ha svelato una situazione già complessa, nel momento in cui ti ritrovi anche senza concerti, ti rivela che la situazione era già al limite. Questa crisi ha svelato anche un aspetto secondo me cruciale: nel momento in cui si toglie la dimensione del concerto, anche fosse il baretto di provincia, si svela un incredibile paradosso. Bisogna essere coscienti che se internet è un mare infinito, è vero che tutti possiamo buttarci in acqua e vedere che cosa succede. Ma questo mare è sconfinato: da lì a essere pescati ce ne corre.
Invece bisogna ripartire dal contatto diretto con le persone: è vero che noi abbiamo cento persone circa che hanno dimostrato che sono disponibili a darci una decina di euro in cambio della nostra musica. Queste cento persone sono il frutto del lavoro di dieci anni. Dieci anni in cui il mondo è cambiato e sono successe tante cose, ma una che non è cambiata è che ci abbiamo sempre tenuto a metterci a confronto e faccia a faccia con gli ascoltatori, organizzando dei festival, suonando ovunque e comunque.
Questo ti rende una persona vera e tangibile di fronte a un’altra persona: è lì che si instaura un contatto. Io non credo che un giovane debba dedicarsi a Instagram, Tik Tok e basta: nel caso immaginario che tra un mese tutti i server scomparissero, si trovano senza follower e svaniscono perché non hanno un contatto diretto. Un concerto brutto te lo ricordi, anche soltanto come concerto brutto. Ma i mille video che ti vedi scrollando sul cellulare non sono qualcosa su cui basare il proprio percorso di vita.
Parliamo del disco a questo punto direi… Come mai così presto dopo Deserto e quali sono state le ispirazioni di Sale?

Abbiamo iniziato a lavorarci circa un anno fa, a ottobre 2019, poco prima che uscisse Deserto. Eravamo stremati dall’esperienza e avevamo voglia di lavorare in un modo diverso per vedere se eravamo in grado. Se non ci fosse stata la pandemia, secondo la nostra tabella di marcia il nuovo disco sarebbe uscito in aprile-maggio.
Ci sono stati sei mesi dopo il blocco obbligato di marzo, siamo riusciti a registrare a partire da luglio. Le motivazioni artistiche, molto semplicemente, sono state quelle di andare oltre il disco precedente, sotto tutti i punti di vista. Deserto era un disco in cui ognuno aveva la sua posizione e quindi ognuno porta una canzone, ci si lavora assieme e diventa una canzone del disco, ma è un metodo che non ci è piaciuto, perché non porta a una vera condivisione delle emozioni e della musica.
Ci siamo detti: proviamo a fare l’opposto. Ogni nota che senti in Sale è nata esclusivamente dall’interazione di almeno due persone. Quando abbiamo cliccato per la prima volta “rec” e il microfono ha iniziato a captare un segnale e registrarlo, tutto questo è partito da un’interazione. Non c’è mai stata la composizione di qualche materiale prima: ogni suono è stato creato da almeno due persone, se non da cinque, con il produttore artistico, Francesco Ambrosini, che è anche uno dei fondatori della band.
Questa è la grande novità: per quanto ci siamo sempre definiti un collettivo non avevamo mai applicato un processo collettivo al 100%. Anche i testi sono comunque nati sul momento in risposta a frasi dette da qualcuno. Sono mischiati ed elaborati insieme. Questo per alcuni artisti può essere la norma: mi vengono in mente i Can, che facevano musica palesemente nata dalle improvvisazioni e dall’interazione, per quanto poi arrivasse ad avere una struttura pop.
Noi abbiamo cercato di fare la stessa cosa: ci siamo chiesti se eravamo capaci di fare delle canzoni pop improvvisando. Perché un conto è fare del free jazz. Ma noi volevamo avere una struttura con strofe, ritornelli, ponti, strumentali, ma che lasciasse l’impressione di essere qualcosa di conciso e strutturato. Siamo partiti non dico dal caos, ma dalla casualità che si genera dagli incontri, e non hai idea di che cosa genererà questa moltiplicazione esponenziale.
Guardandovi allo specchio, qual è la percezione di voi come band che avete in questo momento?
Musicalmente, abbiamo abbandonato il concetto di “genere”. Abbiamo aperto più porte possibile, non nel senso di fare le cose a caso ma di non precluderci niente. Tantissimi paletti sono quasi sempre autoimposti. Poi quando ti rendi conto che te li stanno imponendo altre persone o circostanze intorno a te sta a te decidere di svincolarti o meno. Non siamo vincolati da condizioni contrattuali o personali dannose.
Quindi nel momento in cui ci si rende conto che potenzialmente si è liberissimi, da un lato si rischia di perdersi, in senso assoluto, perché se non hai idea di cosa fare può essere molto disorientante. Ma da un altro punto di vista, per quanto abbiamo sbattuto la testa in mille occasioni, abbiamo anche cercato di tenerci molto in movimento.
Si tratta di conciliare una forma e una struttura che in senso artistico è quello della canzone pop. Leggo che la consapevolezza di Battiato nel fare le canzoni è quella di dire che ha trovato nella canzone pop la forma più consona per veicolare un messaggio o un’emozione. Vuol dire che se lui l’avesse trovata nel fare un film, che ha fatto, un’opera lirica, che ha fatto, o un libro, avrebbe scelto altre forme di veicolazione. Al momento abbiamo scelto la canzone pop, ma con le stesse intenzioni poteva venire fuori un disco strumentale lungo quattro ore…
Tutti dicono di essere unici e in un certo senso è vero: tutti abbiamo la nostra voce e abbiamo la possibilità di affinarla e renderla più consona a noi stessi. In questo momento stiamo cercando noi stessi. Inevitabilmente siamo dentro vari sistemi, in questa società. Se devo pensare a come ci vediamo allo specchio direi questo: nel momento in cui ci siamo accorti che il sistema in cui siamo inseriti non ci torna, o ne usciamo, oppure facciamo qualcosa per cambiarlo dall’interno.
Numeri di vanità
Questo articolo non è non vuole essere un atto d’accusa contro nessuno, e men che meno contro Spotify (o i suoi concorrenti come Deezer, Apple Music e compagnia). Tanto è vero che in quasi tutti i nostri articoli, tipo questo continui a trovare il link ai dischi o alle canzoni in streaming che sono quasi sempre contrassegnate dal loghino verde e nero. E tanto è vero che avremmo tenuto a far sentire anche la voce di qualcuno di Spotify. Ma alla nostra richiesta di un’intervista, l’ufficio stampa italiano ci ha risposto:
“Le info e i dati disponibili li puoi trovare sul blog “For the record”. Per l’intervista purtroppo per il momento non abbiamo possibilità”. (Ufficio stampa Spotify)
Una scelta che rispettiamo, ovviamente. Magari ci riproveremo più avanti in un’inchiesta allargata che coinvolga anche gli altri giganti dello streaming. Spotify, che usiamo come simbolo per tutte le piattaforme con le stesse caratteristiche, ha difetti (ma ehi, ne ho anch’io, per quanto pochissimi). Ma non è certo il diavolo e dà la possibilità a tutti gli artisti di avere una presenza digitale in un mercato universale. Prima di Spotify, ricordiamolo, c’era la processione con i demo in mano alle etichette e alle case discografiche, che non è che fosse proprio una bella vita.

E dal lato utenti, che poi siamo tutti, musicisti compresi, consente di avere musica a portata di mano senza svenarsi né sentirsi dei pirati come era in epoca Napster/eMule/torrent eccetera. Chiaro che se sei un musicista e speri di diventare ricco grazie alle royalties che ti arrivano, ecco forse è meglio se ti procuri un piano B. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Galassi, giornalista con una quantità di collaborazioni pressoché infinita (che gli invidio in realtà molto, ma non quanto gli invidio la foto da Rockstar che pubblico qui accanto) tra cui Billboard Italia, Left, Il Fatto Quotidiano, insegnante, collaboratore del MEI e grande esperto di music business.
Partiamo dai C+C: hanno fatto qualcosa di leggermente diverso dal solito. Come la vedi?
Ogni cambiamento o tentativo di cambiamento è sempre bene accetto. E’ un po’ anche il lavoro dell’artista. Forse ci siamo addormentati negli ultimi anni, con queste storie dei numeri di YouTube, di Spotify, di Instagram, numeri di vanità, che sono più importanti per l’artista che non per quello che significa per il mercato musicale.
Sono molto concentrati su se stessi, ma non sulla musica che fanno, bensì sui numeri che vogliono raggiungere, senza sapere bene che cosa farci, poi, con quei numeri. Tutto questo ha fatto perdere un po’ di vista, anche a noi pubblico, il senso della musica: l’artista ha bisogno, anche per essere tale, di distruggere le regole.
Noi abbiamo necessità di persone che “cambiano modo”, che ti rinnovano, che buttano il vecchio e ti fanno vedere in faccia qualcosa di nuovo.
L’operazione dei C+C è interessante in questo senso. Del resto guadagnare più di quello che raccogli su Spotify non è difficile: non bisogna pensare a Spotify come un guadagno, ma è solo che se non ci sei, rischi che nessuno si accorga di te. I C+C hanno il loro pubblico, la loro community legata, quindi in qualche modo possono “spostare”.
Perciò su Bandcamp vendono in qualità più alta, ed eventualmente potrai venderlo anche in versione cd e anche il merchandising. Lo vendono a 13 euro e l’utente causale potrebbe dire: va be’ con 13 euro faccio l’abbonamento a Spotify per un mese, ascolto tutto quello che voglio e mi avanzano anche dei soldi. Però loro stanno lavorando su un altro concetto: avere un rapporto più diretto artista-pubblico e anche scardinare il concetto secondo il quale devi sottostare a determinate regole imposte da Spotify e, in qualche modo, sottoscritte dalla Siae.
Perché quando Spotify decide di pagare 28 millesimi di euro per singolo play, non è che lo decide da solo: lo decide insieme alle società di collecting. Non proprio la Siae ma altre società che riferiscono alla Siae. E’ un prezzo bassissimo in base al quale devi fare milioni di ascolti per guadagnarci.
Sicuramente è qualcosa di cui c’è bisogno. Poi a me piace tantissimo perché Bandcamp è una delle piattaforme più interessanti ora sul mercato per un musicista. E’ il modo migliore per sostenere una band. Ma c’è anche il lato rivoluzionario: è un buon modo per abituare l’ascoltatore a fare altri giri, a non percorrere sempre lo stesso percorso. Anche perché in questa maniera diamo un eccessivo controllo e responsabilità a Spotify per decidere la musica per noi.
Io per un anno non mi sono liberato dei Pinguini Tattici Nucleari, di Franco 126 e di Aiello, me li trovavo in ogni playlist. Siamo partiti da uno stereo in cui mettevi la tua cassetta e premevi “play”, ora abbiamo uno stereo che ti dice che cosa ascoltare. Fighissimo, bellissimo, contemporaneo, ma anche un po’ preoccupante.
I C+C hanno fatto benissimo e dovrebbero fare così anche band che sono riuscite a costruirsi negli anni una nicchia, soprattutto quelle che hanno una nicchia internazionale. Se si cerca un modo di monetizzare la propria musica, soprattutto in questo momento in cui non si possono fare concerti, questo è il modo giusto. Perché veramente prima di fare 13 euro su Spotify hai voglia degli ascolti che devi fare… In più ogni tipo di transazione ti rilascia un indirizzo mail, a cui puoi spedire una newsletter. Gli artisti dovrebbero un po’ iniziare a non appoggiarsi esclusivamente su Spotify.
Pensi che sia un approccio valido anche per gli esordienti oppure soltanto per chi ha già una fanbase cospicua e consolidata?
E’ veramente difficile capire: Billie Eilish, per esempio, è esplosa su Soundcloud. Poi da lì contratto, ed è diventata quello che è diventata. Non c’è una legge. Proprio perché il mondo della musica è toccato dalla magia e la magia è qualcosa di imprevedibile. Il discorso della promozione canonica: distribuisci il brano, vai nei digital store, fai la promo, il video lo metti su YouTube, poi fai il pitch per le playlist, non ti segue nessuno e allora paghi qualcuno che ti metta nelle playlist… E’ un approccio che in pochi anni si è canonizzato, quasi si è incancrenito.
Guarda anche le pubblicità che ti arrivano su Instagram, sono tutte uguali: “Fuori ora”, “Fuori ora”, “Fuori ora”. Nome dell’artista, la copertina, o niente o un’immagine del videoclip. Sembra di far parte non dell’industria musicale, ma dell’industria delle lavastoviglie. Dove ormai si sa che la lavastoviglie si vende in quella maniera e si vende così. Non vedo niente di stimolante. A parte che non ascolto niente di stimolante, però questo è un altro discorso.
Almeno con l’esperimento su Bandcamp c’è un controllo del flusso. Anche il sito che le band non fanno più, la newsletter… Almeno è qualcosa di tuo. Se non lo fai, dai il traffico a qualcun altro: a Spotify, al plugin che ti gestisce i follow su Instagram, a Facebook, a TikTok. Non sei padrone di niente, dai tutto in affitto. La tua vita e i tuoi dati sono in affitto a qualcun altro. Se questo chiude, boom: i tuoi dati, il tuo volume, la tua popolarità, la tua celebrità se ne vanno a quel paese.
Qualcosa che è già successo, con MySpace, e in parte è successo anche con Facebook, con questo calo clamoroso che c’è stato negli ultimi anni. Gli artisti sono un po’ narcotizzati dietro a questi numeri di vanità. Se il mio video ha milioni di views vengo considerato migliore di un altro che ne ha meno, pur non indicando la qualità. In questo mondo di “capitalismo musicale” dove vincono i numeri stiamo troppo rincorrendo la vanità che questi numeri dimostrano”.