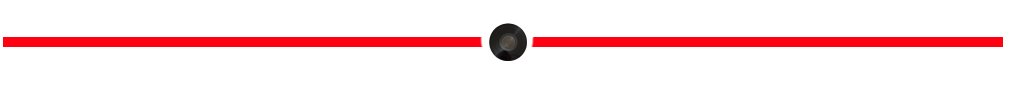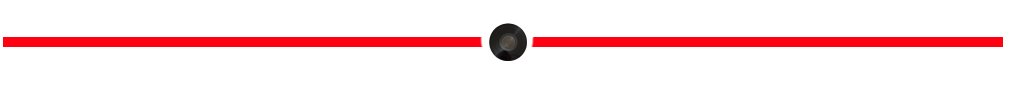
I have loved you, I have grieved
I’m ashamed to admit I no longer believe
I have loved you, I received
I have traded my life
For a picture of the scenery
Don’t do to me what you did to America
“AMerica”, sufjan stevens
Fa abbastanza spavento constatare che Sufjan Stevens ha iniziato la sua carriera da solista più di vent’anni fa, nel 1999, e che ha già alle spalle sette album in studio, con The Ascension, il nuovo lavoro, a costituire l’ottava pietra miliare di una carriera che però si tende a considerare ancora “giovane”.
Il nuovo lavoro arriva a cinque anni dall’ultimo disco di inediti, il davvero considerevole Carrie & Lowell, e a tre dalla colonna sonora di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, che ha fatto parzialmente uscire anche da noi dalla nicchia il talento cristallino e le bizzarrie del cantautore originario di Detroit.
Stevens porta con sé l’etichetta di “cantautore cristiano“, per via di una fede alla quale fa riferimento qui e là nel corso della propria produzione, ma ciò non gli impedisce di capire e restituire la contemporaneità con una sensibilità del tutto adatta e versatile. Si dirà: che c’entra la sua fede con la sua produzione musicale?
Il cantautore non è un mestiere come gli altri. Ci sono altre professioni che non si fanno necessariamente influenzare dalla spiritualità di chi le svolge. Ma il cantautore prende pezzi di se stesso (o almeno dovrebbe) e li mette su pentagramma (ok dai, su Ableton) senza mascheramenti. E se c’è qualcosa che sembra, almeno a me, alieno dai sentimenti, dalla contemporaneità, dal mondo del 2020, è la mentalità religiosa. Non perché non abbia cittadinanza, ma perché si è dimostrata del tutto inadatta a interpretare il presente.
Eppure Sufjan osserva attraverso la propria lente, si costruisce dei mondi, racconta storie ma è sempre sul pezzo, sia dal punto di vista dei testi sia da quello musicale. Il suo nuovo disco affronta una piccola svolta verso l’elettronico: partito con i crismi del folk, qui reagisce al presente tuffandosi faccia avanti sui synth, con effetti che però si adattano molto bene alla sua poetica morbida ed eterea.
Sufjan Stevens: maneggiando manopole e pensieri
Make me an offer I cannot refuse è il titolo del primo brano ed è anche lo “statement” che apre il disco di Sufjan Stevens: un’offerta che non si può rifiutare fa pensare alla narrativa del Padrino, ma qui l’aria è mobile, i pensieri fluidi, non c’è traccia di vintage o di vestiti gessati e accenti siciliani. Al contrario il cantautore celebra l’adesione all’elettronica sperimentando e maneggiando manopole, con effetti, echi e un pizzico di ansia mascherata da festa.
Un invito alla fuga, celebrato con accenni elegiaci, arriva con Run Away With Me, canzone che si solleva piano e porta tutto su altri livelli, con leggerezza. Una serie di “I don’t wanna be” caratterizzano Video Game, ritmata e, questa sì, portatrice di qualche memoria vintage, e perfino di qualche tastiera che in Italia chiameremmo “indie”. “I don’t wanna be your Personal Jesus” assomiglia a una citazione depechiana, ma forse è una coincidenza, così come il titolo del brano che fa pensare a Lana Del Rey.
Lamentations viaggia nello sperimentale e nello scomposto, pasticciando un po’ con l’elettronica. Sufjan ci stende sopra un cantato leggero e su note alte, con qualche tentazione simil-dance che fanno prorompere tutto il talento pop che dorme sotto la cenere. Si può pensare a Beck, ma con il colpo della spiritualità sempre in canna.
Una richiesta di amore, che sembra piuttosto universale però, arriva da Tell Me You Love Me, che con cori e suoni di una certa delicatezza accentua le caratteristiche soft e soffuse del brano, come in un abbraccio collettivo.
Abbastanza semplice la linea, ma anche il pensiero, che contraddistingue Die Happy, sinuosa e abbastanza radioheadiana (degli ultimi dischi) nel suo ripetere il mantra “I wanna die happy” per tutto il brano.
C’è un che di fantascientifico e di ossessivo in Ativan, che procede a rotazione e si fa incombente, rumorosa e anche parzialmente gridata, soprattutto dalle voci sullo sfondo, mentre Stevens in primo piano mantiene la calma nella voce, a prescindere dal background.
Ritmiche scomposte e un panorama sonoro piuttosto contrastato fornisce supporto a Ursa Major, che è astronomica soprattutto nel finale. Atmosfere più tranquille, anche se per niente placate, quelle che si respirano in Landslide, piena di piccoli luccichii, costruita con delicatezza.
Si viaggia indietro nel tempo e nel mito con Gilgamesh, che ha un passo rallentato e più faticoso, come a portarsi dietro il peso dei millenni, ma che parla di cuore e di sogni. Viene in mente O come O come Emmanuel, per fare un paragone con la storia del cantautorato di Stevens, ma qui l’afflato religioso è meno potente, in un brano che comunque si stacca dalle sonorità del disco.
Death Star fa tornare ai suoni elettronici e decolla verso cieli galattici (Death Star è anche il nome originale della Morte nera in Star Wars). La canzone si riversa quasi senza interruzione in Goodbye to all that, che condivide ritmi e temi con il brano precedente.
Ci si immerge in sotterranei con Sugar, che si allunga oltre i sette minuti e mezzo pur conservando caratteristiche spiccatamente pop. Quello che sorprende sempre, circa in tutti i dischi del cantautore americano, è la perfetta convivenza di aspetti sperimentali e folli con una fruibilità pressoché totale, dote non proprio comune.
Ecco la title track e il suo sguardo verso l’alto: The Ascension in effetti segue una certa verticalità, ma anche qui c’è gentilezza e morbidezza diffusa ovunque, come a galleggiare su nuvole sonore.
Il disco si chiude con una più “politica” America, che non è proprio Bob Dylan ma che mette sul tavolo un paio di questioni, sempre con toni tranquilli, ma con un brano che si allunga fino oltre i 12 minuti, in cui il sentimento prevalente è la disillusione.
Quindici canzoni per un disco molto lungo. Ma del resto non è da Sufjan Steven spaventarsi di fronte alle lunghezze o alle imprese difficili (una volta progetto di pubblicare un disco per ognuno dei cinquanta Stati Uniti, poi iniziò a farlo veramente, poi disse che scherzava). Ma su questo disco si galleggia, si aleggia, ci si svapora e ci si ricompone, inseguendo sfaccettature e dettagli, accompagnati da una voce che qui si fa ancora più angelica del solito.
Ma c’è anche un movimento interno nel disco, che nella prima parte sembra aver bisogno di emergere e di sgomitare quanto possibile, e che con l’andare dei brani sembra placarsi. Al contrario i testi a volte sono slegati dagli umori della musica, mettendo in evidenza sensazioni differenti e piani diversi.
Il risultato probabilmente non è il miglior disco della sua carriera, soprattutto per chi apprezzava il minimalismo di alcuni precedenti. Ma è sicuramente una svolta importante, nonché la conferma di una creatività sempre molto viva, attenta e sensibile.